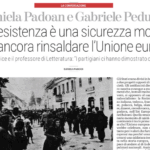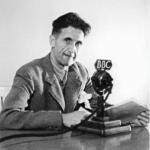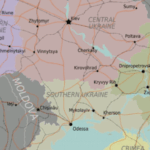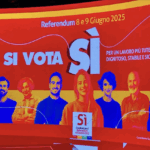Dire chi è stato Alessandro Pace è impresa che non può esaurirsi in un momento, e soprattutto quando il dolore per la sua scomparsa è attuale. Da allievo affezionato, mi limiterò ai ricordi più vivi e scolpiti nella memoria.
Studente del primo anno di giurisprudenza, immatricolato nel 1976, lo ebbi all’Università di Firenze come docente di istituzioni di diritto pubblico (materia che allora, nel piano di studi della facoltà, prendeva il posto che era del diritto costituzionale nel piano di studi nazionale). Almeno al primo anno, le lezioni erano molto frequentate, comprese le sue. Inizialmente, si stentava un poco a entrare in sintonia con lui, perché il suo livello intellettuale superava nettamente quello medio di una “matricola”, ma appena superati i primi ostacoli comunicativi, il suo carisma affascinava e induceva molti a frequentare non solo le sue lezioni, ma anche i seminari, che egli teneva talvolta con l’aiuto di collaboratori (quelli che un tempo si chiamavano assistenti), ma sempre seguendoli anche personalmente, ed in cui appresi per la prima volta come si leggeva una sentenza.
Le sue posizioni politiche, in un clima surriscaldato (anche se alla Facoltà di Giurisprudenza di Firenze meno che altrove), sulle prime sorprendevano per la loro moderazione, e per la tecnicità con cui affrontava le questioni. Ricordo che in una delle prime lezioni, per spiegarci il problema della legittimità costituzionale di leggi non aventi carattere generale ed astratto (le cosiddette “leggi-provvedimento”), ci fece l’esempio dei decreti legislativi attuativi della riforma agraria, al che io alzai la mano per chiedere la parola e, avutala, lessi l’art. 44 della Costituzione, poiché mi pareva strano che si potesse dubitare della legittimità costituzionale di una riforma così espressamente delineata dai padri costituenti! Naturalmente avevo frainteso il problema di forma con quello di sostanza, ed egli ebbe la bontà di spiegarmelo e farmelo capire, introducendomi alle problematiche dell’argomentazione giuridica, che è ben altra cosa da quella politica.
Pur mantenendo sempre quell’innato stile signorile che lo distingueva, sapeva infatti entrare facilmente in comunicazione con gli studenti, aiutandoli a comprendere le difficoltà della materia e del linguaggio tecnico. Come ho ricordato, la lettura e il commento delle sentenze della Corte costituzionale era la materia prima dei suoi seminari. Accanto alla sua immensa produzione scientifica, che viene ricordata nei primi commenti alla sua scomparsa, andrebbero ricordate anche le sue capacità didattiche.
A Firenze, dove rimase alcuni anni prima di tornare a Roma (dove aveva casa, famiglia e studio professionale), si trovava bene, e la lasciò con rimpianto, anche se per formazione culturale non era perfettamente in sintonia con la scuola di Paolo Barile. Pace fu infatti, a differenza del caposcuola fiorentino, un giuspositivista (sebbene “temperato”, come egli diceva, precisando che del giuspositivismo accettava il metodo e non i presupposti ideologici) al pari del suo maestro Carlo Esposito. La scelta del metodo giuspositivista temperato, contrapposta all’interpretazione per valori, era da lui giustificata da tre elementi:
a) dalla piena adesione ai valori liberaldemocratici, che vieta di dar spazio alle opzioni soggettive dell’interprete;
b) dall’ampiezza e sufficiente esaustività dell’articolato della Costituzione, che non necessita come altre di colmare lacune;
c) dalla natura stessa del costituzionalismo nel significato di teoria giuridica dei limiti del potere politico, che impone il rispetto del testo limitando le possibilità creative dell’interprete (dove si annida il rischio di interpretazioni arbitrarie, il soggettivismo di molti “bilanciamenti” tra valori, e l’abuso del criterio di ragionevolezza).
Forse gli avrebbe dato ragione un altro antico maestro fiorentino, Piero Calamandrei, che nel 1940 affermava che “tra i compiti specifici dei giuristi, tra i metodi della loro tecnica professionale, non vi è, e non vi deve essere, quello della audacia rivoluzionaria che va oltre lo jus conditum e spalanca allo jus condendum le porte dell’avvenire”.
È comprensibile perciò che, con tali idee, e nonostante il valore scientifico, implicitamente riconosciutogli con la presidenza dell’associazione italiana dei costituzionalisti, non gli sia mai stata offerta la carica di giudice costituzionale, che comporta una disponibilità a comprendere le ragioni del potere adattando ad esse i “valori”, e soprattutto il testo, della Costituzione. A differenza di quanti sostengono il metodo opposto a quello di Pace, e che hanno addirittura trasformato (sono le parole di Pace) l’etichetta di “giuspositivista” in un insulto a chi ne utilizza il metodo, la libertà dell’interprete in generale, e del giudice in particolare, non è affatto intrinsecamente ostile al potere, ma ben può essere utilizzata per assecondare le torsioni a cui il potere pretende di piegare la Costituzione e le leggi. Molto spesso (anche se non sempre) chi segue tendenze anti-formaliste ha anche la vocazione di “consigliere del principe”.
Ma proprio le prese di posizione “politiche” di Pace, e le difese assunte in giudizio, oltre alle sue riflessioni scientifiche in tema di libertà, smentiscono la teoria culturalmente egemone, che indica nel giuspositivismo una tendenza reazionaria (come se non fosse un prodotto dell’illuminismo e della rivoluzione francese). Fin dalla comparsa delle televisioni private, fu oppositore della illusoria “libertà di antenna” (fece parte del collegio difensivo della Rai nel procedimento che dette vita all’infelice sentenza della Corte costituzionale n. 202/1976, che ammise le tv private via etere “in ambito locale” senza dire che cosa si dovesse intendere per tale: un esempio di libertà dell’interprete che non ebbe conseguenze politicamente progressive) e poi degli abusi che ne seguiranno, dai decreti-legge ad personam alle palesi violazioni dei diritti di chi si era aggiudicato concessioni con regolare gara, ma dava fastidio all’oligopolio. Difese la magistratura in molti conflitti di attribuzione davanti alla Corte costituzionale (tra i più rilevanti quelli sui casi Abu Omar e sulle intercettazioni del Presidente Napolitano), pur essendo assertore di un’interpretazione non restrittiva dell’art. 28 della Costituzione, sulla responsabilità dei pubblici funzionari, anche se magistrati.
Ma a farlo conoscere ad un pubblico più vasto di quello dei soli studiosi fu soprattutto la difesa strenua della Costituzione dagli attacchi del potere politico che voleva stravolgerla, nel corso delle due campagne referendarie conclusesi vittoriosamente per la Costituzione vigente, quella del 2006 contro la riforma berlusconiana, e quella del 2016 contro la riforma renziana. In quest’ultima egli assunse anche la presidenza del Comitato per il no. Furono circostanze nelle quali avemmo modo di ritrovarci, sempre reciprocamente ricordando con affetto egli lo studente, ed io il Maestro.
Chiuse così in bellezza una splendida vita di studioso e di uomo, prima che lo rattristasse la perdita della sua cara sposa Loretta, che ora ha finalmente raggiunto.
Leggi anche l’articolo di Rainews
È morto Alessandro Pace