La piazza è luogo d’incontro di grandi numeri. Si è in tanti; ci si va, spontaneamente o obbligatoriamente, ci si incontra tra conoscenti e sconosciuti ma con qualcosa in comune che viene “messo in piazza”, cioè “manifestato”. Ma di piazze politiche non ce n’è una sola. Possono essere luoghi di radunate obbligate dove si respira rinuncia, passività, tristezza: in una parola, si manifesta l’oppressione. Ma possono anche essere luoghi spontanei di assemblea dove si respira passione, leggerezza, calore: in una parola, si manifesta la libertà.
Radunate e assemblee si svolgono in piazza, ma sono cose opposte. Le radunate le conosciamo bene. Sono strumenti di acclamazione di massa, organizzati dall’alto a sostegno dei despoti e a intimidazione del dissenso: per esempio, i nazisti nello stadio di Berlino, i fascisti in piazza Venezia, i sovietici sulla Piazza Rossa di Mosca, i cinesi sulla piazza Tienanmen di Pechino, i coreani sulla piazza Kim II Sung a Pyongyang. Altrettanto bene conosciamo le manifestazioni convocate dal basso per dare voce al dissenso: per esempio, Occupy Wall Street e gli “Indignados ” della Puerta del Sol di Madrid contro la grande finanza, i giovani delle “primavere arabe” contro le autocrazie islamiche e, risalendo indietro, le proteste di massa contro il governo Usa e la sua guerra in Vietnam. La differenza politica sostanziale è nell’“ordine del giorno”. L’ordine del giorno delle radunate è semplice, chiaro e tassativo: la celebrazione. Delle assemblee, al contrario, può essere generico e solo iniziale, venendosi a precisare nel corso dei lavori. «Io vado in piazza per questo; tu per quest’altro; un terzo per quest’altro ancora, ma tutti ci andiamo».
C’è contraddizione e dovremmo stare tutti a casa?
No, se siamo uniti su una cosa comune, per così dire primordiale, la liberazione da un male comunemente avvertito e insopportabile. Questo è solo un punto di partenza su cui si può concordare: un rifiuto. È già molto perché da lì possono aprirsi molte strade che, in embrione, stanno nella negazione di ciò che rifiutiamo. La negazione del negativo è l’apertura alla affermazione. Per esempio, essere contro la violenza significa essere per la mitezza; contro la menzogna, essere per la verità; contro la guerra, essere per la pace; contro la morte, essere per la vita. Mobilitarsi “contro” riguarda il momento pre-politico o, forse, iper-politico perché in esso si concentrano tutte le ragioni, le speranze e le difficoltà dello stare insieme nella pòlis , a onta delle differenziazioni che alimentano la politica d’ogni giorno. Queste sono inevitabili. In democrazia sono anzi necessarie e hanno il loro momento. Ma verranno dopo e riguarderanno le concezioni, le vie, i mezzi per la costruzione del lato positivo, alternativo a ciò che, insieme, sia stato rifiutato. Rifiutata la guerra, ci sono molti modi per costruire la pace. Ci sono i non-violenti, i pacifisti gandhiani e tolstojani, i “beati costruttori di pace” che si ispirano al messaggio evangelico, gli obiettori di coscienza e i renitenti alla leva, coloro che lavorano per l’uguaglianza, la giustizia, la comprensione e la collaborazione tra i popoli, i federalisti che osteggiano la sovranità degli Stati, gli ecologisti per i quali la terra è “bene comune”, gli animalisti che rispettano ogni forma di vita, i cosmopoliti che combattono i nazionalismi, i movimenti per i diritti civili, il rispetto della vita animale e vegetale, coloro che si oppongono a ogni “suprematismo” razziale o culturale e alla legge del più forte, di cui la guerra è la più terribile conseguenza, coloro che confidano nella “pace attraverso il diritto”; infine, o forse all’inizio di tutto, coloro che considerano i conflitti il risultato estremo e fatale della logica dell’accaparramento mercantile nei rapporti tra popoli, nazioni e Stati. Sono tanti, poi, coloro che, senza ragionamenti filosofici o politici, semplicemente hanno la guerra in orrore, e hanno invece in onore istintivamente il comandamento “non uccidere”, non distruggere, non violentare. Sono (siamo) in tanti, sconcertati a guardare un mondo che mai come oggi è dominato dalla guerra: guerra che si fa, che si minaccia, da cui ci si difende ancora per mezzo della preparazione di altre guerre. Il diavolo, il seminatore di discordia, sembra scorrazzare liberamente. Al più, concede qualche tregua promossa da chi ne approfitta per prepararsi meglio alla prossima occasione. Siamo sconcertati e, finché stiamo da soli, siamo immersi nella nostra frustrazione e nella nostra impotenza. Tutte le motivazioni, per molti rivoli, possono confluire in un movimento per la pace che tenga insieme le diversità.
Occorre, però, saper distinguere i tempi.
C’è un tempo per ogni cosa, il tempo per l’unione e un tempo per le differenze. Ora è il tempo dell’unione, poi verrà quello delle differenze. Sarebbe un errore confonderli. Questo sarebbe ciò che si chiama, precisamente, settarismo. Ricordiamo che se le forze politiche antifasciste negli anni ’43-’45 avessero fatto questa confusione, la resistenza al fascismo sarebbe morta sul nascere. Fin qui la pace. E l’Europa? “Una piazza per l’Europa” è un’ellissi. Non basta dire e ripetere dieci, cento, mille volte “Europa” per sapere ed essere d’accordo o in disaccordo su che cosa effettivamente si vuole “scendendo in piazza”. L’Europa è un’aspirazione del movimento federalista che ha coltivato e ha tenuta viva l’idea originaria: non uno “Stato in grande” della stessa pasta di cui erano fatti gli Stati dell’Ottocento e del Novecento, gli Stati sovrani il cui imperativo era la potenza: “Stati di potenza” è il loro nome, in perenne competizione tra di loro, sovrani dentro e fuori i propri confini, armati per difendersi dalle mire altrui e coltivare le proprie. La guerra è nell’essenza di questi Stati. Essi, la pace, la mercanteggiano perché è una merce come un’altra e, per interesse e convenienza, l’acquistano minacciando guerra o la conquistano facendola. Questo orrendo simulacro di pace contiene violenza, distruzione e morte e può condurre, piano piano o in un colpo solo, per decisione, errore o imprevisto, alla “pace dei cimiteri”.
I saggi di Ventotene, il cui Manifesto è oggi così frequentemente citato, avevano ben chiaro che il pungiglione sta nella sovranità e che la via della pace sta nel renderlo inoffensivo. Moltiplicare i signori della guerra è davvero il modo per neutralizzarlo e percorrere le vie della pace? Ne esistono altri? Altri, diversi dalla crescita degli arsenali militari, diversi dall’occupazione del pianeta con potenze armate fino ai denti (atomici) che, sentendosi reciprocamente minacciate da altre potenze, si guardano in cagnesco sulla base del sospetto e, perciò, per non soccombere, ingaggiano una folle corsa al potenziamento dei propri armamenti? L’Europa tenta di prendere le distanze o si sta semplicemente omologando? I suoi dirigenti sempre sorridenti sembrano ignari. Sembrano accettare che la guerra sia il sottinteso necessario d’ogni possibile politica, anche della politica per la pace: si vis pacem para bellum, il suicida motto ritornato in auge dopo che immani tragedie sembravano averlo esorcizzato. Sembrano privi di altre idee, di strategie per la propria sicurezza che facciano leva sulla forza diffusiva della pace senza guerre: una forza che in questo momento sembra dimenticata e aspetta di essere suscitata.
La piazza del 15 marzo è facile capire che cosa sarà e da che parte starà. Starà dalla parte dell’Europa, ma non di un’Europa qualunque, né tantomeno di un’Europa che si vota a un cieco riarmo. Starà dalla parte, si può credere, dell’Europa fedele a sé stessa.
Difendiamo la Costituzione, i diritti e la democrazia, puoi unirti a noi, basta un piccolo contributo






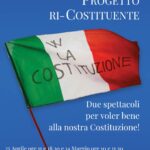

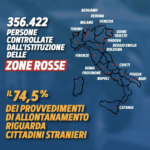






 Roberta De Monticelli
Roberta De Monticelli
 Domenico Gallo
Domenico Gallo


