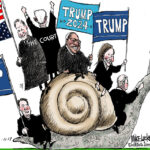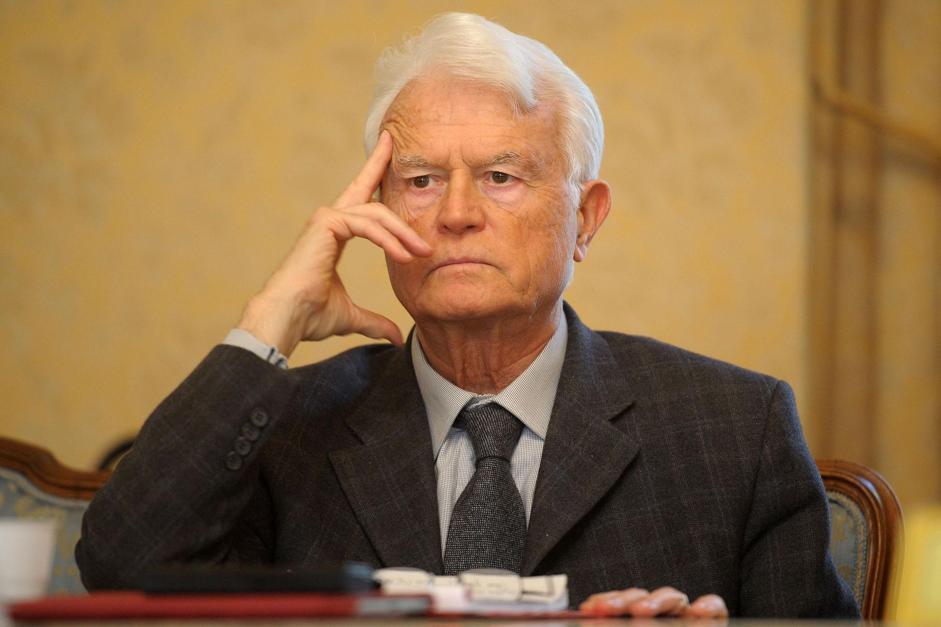Nei primi trent’anni della Repubblica, il sistema giudiziario ha progressivamente manifestato una strutturale inadeguatezza a gestire il crescente numero dei procedimenti penali, per una serie di motivi che non è questa la sede per trattare diffusamente (aumento della popolazione, trasformazioni sociali, aumento del tasso di criminalità, rallentato adeguamento dell’organico della magistratura, obbligatorietà dell’azione penale, aumento delle garanzie processuali).
La risposta della politica è consistita nel continuo ricorso ad amnistie che, a scadenza più o meno prevedibile e ravvicinata, ponevano nel nulla, in relazione alla vasta tipologia di reati (generalmente, e salve eccezioni, quelli puniti con la reclusione prevista per legge nel massimo fino a tre anni) il lavoro di forze dell’ordine e magistratura in qualunque stato e grado si trovasse il procedimento, purché non ancora pervenuto alla sentenza definitiva. Anche in quest’ultimo caso, peraltro, si aveva l’effetto estintivo della cosiddetta “amnistia impropria” che faceva cessare l’esecuzione della pena già iniziata, se il reato commesso rientrava nel provvedimento di clemenza. Se poi non vi rientrava, anche gli effetti di un’eventuale sentenza di condanna definitiva sarebbero stati resi vani dalla contemporanea concessione dei due anni di indulto che accompagnavano puntualmente le amnistie, previsti nello stesso decreto, e che salvavano quei pochi malcapitati che, puniti per reati che esulavano dall’amnistia, non avessero potuto (poiché pregiudicati) beneficiare neppure della più vantaggiosa sospensione condizionale della pena (si pensi ad esempio ad una bancarotta fraudolenta, punita con la reclusione da tre a dieci anni, e quindi potenzialmente comportante, nel minimo e con la concessione di un’attenuante, una condanna a soli due anni). Anche lasciando da parte i numerosi provvedimenti clemenziali dell’immediato dopoguerra, ed in gran parte connessi a vicende politiche e belliche (se ne contano ben 18 tra il 1944 ed il 1949), la cadenza dei provvedimenti di amnistia e indulto della Repubblica, fino all’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, è la seguente: 1953, 1959, 1963, 1966, 1968, 1970, 1973 (per i soli reati finanziari), 1978, 1981, 1982 (di nuovo per i soli reati tributari), 1983 (ancora per i soli reati tributari: si vede che non bastava quello dell’anno prima), 1978, 1986. Senza contare i numerosi condoni fiscali, urbanistici, e simili, che rappresentano “amnistie mascherate” perché condizionano l’estinzione di reati al pagamento di un modesto obolo.
Inutile dire che, in un contesto simile, si poteva dire acquisita nella coscienza sociale la consapevolezza della sostanziale impunità per (quasi: vi erano le esclusioni per determinate ipotesi di maggior allarme) tutti i reati punti sotto la fatidica soglia dei tre anni nel massimo edittale, e la tendenziale impunità per molti altri che superavano tale soglia (o ne erano esclusi per le ragioni anzidette), ma la cui pena era comunque potenzialmente condonabile per indulto. Il ricorso a questa seriale concessione di clemenza (ipocritamente accompagnato, ogni volta, dalla promessa solenne dei politici che quell’amnistia lì “sarebbe stata l’ultima”) ha quindi svolto, assai verosimilmente, una funzione gravemente diseducativa, accentuando nella popolazione la già presente propensione all’illegalità. Ed ha, al contempo, fatto diventare le impugnazioni delle condanne uno strumento finalizzato, più che alla sostanziale riforma della sentenza, al tirarla per le lunghe in attesa della prossima amnistia (con effetti distorsivi anche sulla cultura forense). Il tutto, inoltre, aggravato da una connotazione classista che la giustizia penale veniva ad assumere: perché a beneficiare delle ricorrenti amnistie erano, principalmente, gl’imputati processati a piede libero, per lo più incensurati e “colletti bianchi”, mentre per i reati predatori commessi da soggetti marginali si procedeva (a seguito di arresti in flagranza e/o di mandati e ordini di cattura) con l’imputato in stato di detenzione, il che creava una corsia preferenziale al processo, e faceva sì che, quando arrivava l’amnistia, la condanna fosse già divenuta definitiva, o comunque la pena (inflitta o potenziale) fosse già stata, almeno in parte, scontata di fatto in stato di custodia preventiva.
In questa prima fase della storia giudiziaria repubblicana, la prescrizione assolve ad un ruolo marginale. Le amnistie frequenti e ricorrenti nascondono la disparità tra numero di reati da perseguire e forze giudiziarie disponibili, e non fanno scattare le prescrizioni che, altrimenti, avrebbero rappresentato il segnale di tale asimmetria. Nell’ambiente giudiziario, invece, le prescrizioni continuavano ad essere sentite e vissute come una sorta di scandalo, e nei rari casi in cui se ne verificava qualcuna, sorgeva la necessità, imposta da normative secondarie (oggi desuete o abrogate), di renderne conto ad uffici superiori.
Tutto cambia a seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice di procedura, avvenuta il 24 ottobre 1989, e dei due ultimi decreti di sola amnistia (DPR n. 75 del 1990) e di solo indulto (DPR n. 394 del 1990), a fatica e non senza esitazione emanati dopo la riforma: per rendere credibile la promessa (o la minaccia, a seconda dei punti di vista) che questa volta di amnistie non ce ne sarebbero più state per davvero, e con ciò indurre i rei confessi o palesi a praticare i riti alternativi (patteggiamento in primis) introdotti dal nuovo codice, si intraprende la via della revisione costituzionale, e si giunge così alla legge costituzionale n. 1 del 6 marzo 1992, che modifica l’art. 79 della Costituzione imponendo la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna camera, in ogni articolo e nella votazione finale (maggioranze non richieste neppure per la stessa revisione costituzionale!), per potersi approvare una legge di amnistia o di indulto. Ed in effetti bisognerà attendere il 2003 per aversi il cosiddetto “indultino” (sospensione condizionale dell’esecuzione della pena nel limite massimo di due anni: legge 203 del 2003) ed il 2006 per aversi un indulto vero e proprio (anzi, un “indultone”, stavolta di tre anni: legge n. 241 del 2006). Di amnistie vere e proprie non ce ne sono più state.
Ma poiché permanevano, e anzi si aggravavano (per l’appesantimento che il nuovo codice comportava, soprattutto in ordine ai reati minori), la cause strutturali di inadeguatezza del sistema a far fronte alla massa dei reati obbligatoriamente perseguibili, lo sfogo naturale delle contraddizioni del sistema, non trovando più la strada dell’amnistia, trova inevitabilmente quello della prescrizione, non funzionando come sperato la valvola dei riti alternativi (e ciò, peraltro, come meglio si dirà in seguito, proprio a causa del meccanismo della prescrizione). Le statistiche conoscibili riportano dati esaurienti solo dal 2006, ma che quello della prescrizione fosse divenuta la nuova via all’impunità generalizzata lo si comprende bene dalla tenacia con cui la maggioranza a guida berlusconiana ha perseguito l’approvazione di una delle sue leggi più discusse (per usare un eufemismo): la cosiddetta ex-Cirielli (detta “ex” perché il relativo iniziale disegno di legge, presentato dal deputato di Alleanza Nazionale Edmondo Cirielli, ex ufficiale dei Carabinieri, con intenzioni rigoriste, fu sconfessato dal suo stesso proponente per gli stravolgimenti a cui fu sottoposto durante il procedimento di approvazione).
Ma a questo punto occorre fare un passo indietro e vedere come funzionava la prescrizione del reato nella versione datale dal tuttora vigente (benché in più punti modificato) codice penale, quello predisposto nel 1930 dal Guardasigilli fascista Alfredo Rocco. In sintesi, l’art. 157 di detto codice prevedeva un termine di prescrizione articolato in sei fasce, variabile da un minimo due anni per le contravvenzioni punti con la sola ammenda, a un massimo di venti anni per i reati puniti con reclusione non inferiore a 24 anni (sono imprescrittibili i reati puniti con l’ergastolo). La prescrizione(che viene sospesa in ogni caso in cui il procedimento penale sia sospeso per legge: art. 159), è interrotta da tutta una serie di atti, dettagliatamente indicati, che comportano un impulso al procedimento da parte di organi giudiziari (ad esempio, mandato di cattura, interrogatorio, etc.) tra cui particolarmente importanti il rinvio a giudizio e la sentenza (ovviamente, non definitiva) di condanna (art. 160). L’interruzione comporta che la prescrizione riprende a decorrere da capo; ma con una riserva: se più sono gli atti interruttivi, avverte l’ultimo comma dell’art. 160, “in nessun caso i termini stabiliti nell’articolo 157 possono essere prolungati oltre la metà”. Nella relazione che accompagna il codice, il Guardasigilli Rocco avverte di aver modificato il progetto preliminare, anche in conformità al parere della Commissione Parlamentare, eliminando la previsione che la prescrizione potesse maturarsi solo prima del decreto di citazione a giudizio o del decreto di condanna (non avrebbe più potuto quindi, secondo il progetto preliminare, maturare durante il dibattimento di primo grado, o durante i gradi successivi). Rocco affermava che tali atti, essendo anteriori all’accertamento della colpevolezza, non avrebbero “la forza di apportare un’essenziale modificazione in quelle condizioni che sono presupposte dall’istituto della prescrizione”, non impedirebbero “la così detta forza edace del tempo” (in particolare l’affievolimento delle prove), né manterrebbero vivo l’interesse a punire; e dice di aver “preferito quindi ritornare alla nostra tradizione legislativa, secondo la quale la prescrizione del reato può verificarsi sino al momento in cui si ha una sentenza irrevocabile di condanna”. Rispetto al codice precedente, però, e allo stesso progetto preliminare, Rocco introduce un’elencazione tassativa di atti che possono interrompere la prescrizione, per rimediare ai guasti secondo lui prodotti dalla giurisprudenza che, in presenza di una generica previsione che la prescrizione potesse essere interrotta qualsiasi atto del procedimento, avrebbe “smisuratamente allargata la cerchia” degli atti interruttivi. Nessuna particolare giustificazione viene invece data, nella relazione al codice, della specifica previsione circa l’impossibilità che anche la ripetizione delle interruzioni non potesse far superare il termine iniziale di oltre la metà (norma prevista già, peraltro, dall’art. 93 del Codice Zanardelli).
A dire il vero, la disciplina che era prevista nel progetto preliminare (e che Rocco respinse nella versione definitiva) avrebbe avuto una sua logica, ossia si sarebbe conformata al regime della prescrizione civile: secondo l’art. 2943 del codice civile, “la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione, ovvero conservativo o esecutivo”, e in tale ipotesi, aggiunge l’art. 2945 secondo comma, “la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio”. Ossia, una volta introdotto il giudizio civile, quale che sia la sua durata, la prescrizione resta comunque impedita. Tale disciplina, che discende dal principio secondo cui la durata del processo non può andare a danno della parte che abbia ragione, potrebbe trovare dei limiti nel processo penale, dove ad agire non è una parte privata, ma è lo stesso Stato che organizza i servizi della giustizia. Anche se, andrebbe subito notato, anche in campo tributario, se l’amministrazione finanziaria interrompe la prescrizione in tempo utile, non è che il credito tributario si prescriva successivamente se il contribuente impugna l’accertamento facendo ricorso alle commissioni tributarie, ed il procedimento davanti a queste ultime si prolunghi (il reato tributario, se viene impugnata la sentenza di condanna, invece sì…). Inoltre, in un sistema improntato al principio accusatorio, dove cioè la pubblica accusa viene posta su un piano di parità con la difesa privata, anche la prescrizione penale dovrebbe ricalcare la disciplina di quella civile. E’ questo infatti il sistema vigente nei paesi anglo-sassoni di common law. Si potrebbe lungamente discutere se il nuovo processo penale del 1989, “rinforzato”, per così dire, dall’altrettanto nuovo art. 111 della Costituzione, comporti un processo accusatorio di tipo anglo-sassone, ovvero configuri ancora un ibrido tra tale modello e la tradizione continentale. Ma anche nei paesi di civil law più vicini a noi, non esiste una sistema auto-distruttivo come quello della prescrizione del reato “all’italiana”. L’art. 97 comma 3 del Codice penale svizzero prevede espressamente che “Se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue” (una soluzione identica a quella adottata dalla recente riforma che dovrebbe entrare in vigore in Italia dall’inizio del 2020). In Francia, gli atti interruttivi (che possono consistere in qualsiasi atto di istruzione o di azione giudiziaria, non specificati dal legislatore) possono susseguirsi tra loro, e ogni volta la prescrizione riprende da capo, senza limiti massimi (artt. 7, 8 e 9 codice di procedura penale). In Spagna, la prescrizione s’interrompe quando una risoluzione giudiziale motivata attribuisce un reato ad un soggetto determinato, e riprende a decorrere solo da quando il procedimento si paralizzi, ovvero termini senza condanna (art. 132 Codice penale). In Germania invece esiste un limite massimo, che però è pari al doppio della durata iniziale (§ 78c Codice penale – Strafgesetzbuch). Solo l’art. 121 comma 3 del Codice penale portoghese contiene una disposizione di durata massima per non più della metà oltre il termine iniziale, simile al nostro art. 160 ultimo comma (versione originaria).
Ma torniamo ora alla legge (ex) Cirielli. Nella situazione sopra descritta, sarebbe stato lecito attendersi un allungamento dei tempi di prescrizione. Invece, oltre a rimodulare i termini-base di prescrizione, non più a fasce, ma parificati, per ogni reato, al massimo edittale, la suddetta legge è intervenuta, peggiorandolo, sull’aspetto più discutibile della normativa in vigore, ossia sul termine massimo a seguito di più atti interruttivi, che ora non poteva più superare di un quarto (anziché della metà) il termine iniziale. Si era perfettamente capito quale fosse lo strumento più idoneo a garantire l’impunità, e lo si era voluto perfezionare e rendere infallibile. Contro quella riforma, è bene ricordarlo, insorse, con un appello inascoltato, la maggior parte dei penalisti italiani di ogni fede politica, con in testa Giuliano Vassalli, cioè il padre del nuovo codice di procedura penale, socialista e garantista, che affermò: “l’opinione pubblica reclama ‘certezza della pena’, questa riforma garantisce ‘certezza d’impunità’”. Ma non solo di questo si trattava. La legge in commento, oltre a consentire il superamento del termine massimo per una serie di reati di particolare gravità e allarme sociale (quelli previsti dall’art. 51 commi 3-bis e 3-quater c.p.p.), accentuava anche il carattere classista e discriminatorio del sistema penale, introducendo un doppio regime tra imputati incensurati ( o recidivi semplici), per i quali valeva il regime appena descritto, e recidivi aggravati (recidivi specifici, infraquinquennali, o reiterati) e delinquenti abituali o professionali, per i quali il superamento del termine di prescrizione massimo (a seguito di più atti interruttivi) poteva raggiungere la metà, i due terzi, o financo il doppio (a seconda dei casi) del termine ordinario. La ratio della prescrizione, che comunemente viene ravvisata nel ridotto interesse pubblico a giudicare fatti ormai lontani nel tempo, e pertanto viene, in tutti gli ordinamenti, commisurata alla gravità oggettiva del reato (perciò non si prescrivono, ad esempio, i reati puniti con l’ergastolo, e comunque si prescrivono più tardi i reati puniti con pene maggiori, e viceversa) veniva stravolta commisurando la durata della prescrizione al “tipo di autore”, mirando chiaramente a discriminare i soggetti marginali autori di più frequenti reati, indipendentemente dalla gravità di questi ultimi (e nei cui confronti, peraltro, era già difficile anche prima che scattasse la prescrizione, per gli stessi motivi evidenziati a proposito delle amnistie: più probabile sottoposizione ad arresti in flagranza o a custodia preventiva, che rendono il processo celebrato per direttissima o comunque più veloce perché posto su corsia preferenziale).
L’abrogazione delle “leggi-vergogna” emanate dalla maggioranza di centro-destra (la ex-Cirielli, appunto, nonché la Cirami che reintroduceva la “legittima suspicione”, ed altre) fu una delle promesse grazie alle quali il centro-sinistra vinse (di misura) le elezioni del 2006. Ma tale promessa non fu mantenuta, perché la maggioranza vincente ritenne più urgente fare (con decreto-legge) la guerra ai taxisti per compiacere il Corriere della Sera e i suoi columnist neo-liberisti, e così legittimarsi nei salotti buoni (perdendo magari qualche consenso in quelli meno buoni), mentre sul piano della giustizia (affidata alle cure di Clemente Mastella) si limitò, ovviamente col consenso anche dell’opposizione (e poteva mancare? ) necessario per raggiungere la maggioranza richiesta dal nuovo art. 79 Cost., a rieditare, dopo tanti anni, un indulto (toh, chi si rivede), anzi l’ “indultone” (3 anni di sconto!) di cui pocanzi si è detto, efficacemente definito da un parlamentare della sinistra radicale (ad esso favorevole: quindi non si trattava di una critica) uno “scambio di prigionieri”. Terminata precocemente quella breve esperienza politica, era inutile attendersi qualcosa di buono dalla nuova maggioranza di centro-destra, che infatti lasciò più o meno le cose come stavano. Figurarsi poi se le “larghe intese” raggiunte dopo le elezioni del 2013 potevano portare ad un cambiamento su questi temi.
Senonché proprio l’Europa, che troppo spesso ci impone austerità a e misure neo-liberiste, a volte serve a qualcosa. Le prime avvisaglie sono venute dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo – istituzione non della UE, ma del Consiglio d’Europa, organizzazione molto più vasta e che si occupa prevalentemente di diritti e non di economia – a segnalare che qualcosa non funzionava nel nostro sistema di prescrizione dei reati: ed infatti ben due sentenze – una del 2011, sul caso Alikaj, ed una del 2014, sul caso Saba – condannano l’Italia perché due processi per abusi di forze di polizia si erano conclusi con la prescrizione, in quanto, come si legge nella prima di tali sentenza, “tenuto conto della celerità e della diligenza ragionevoli che si richiedono alle autorità in un tale contesto, l’applicazione della prescrizione appartiene ad una categoria di misure che la Corte considera inammissibili, poiché hanno per effetto di impedire una condanna”, facendo applicazione, in entrambi i casi, del principio, già affermato con riguardo ad altre violazioni dei diritti dell’uomo, e nei confronti di altri stati, che i relativi procedimenti devono necessariamente concludersi con una sentenza che accerti nel merito le responsabilità dei funzionari pubblici coinvolti, e non con una sentenza dichiarativa della prescrizione. La bordata finale è poi arrivata dalla Corte di Giustizia Europea, questa sì istituzione della UE, la quale, con la sentenza n. 105 dell’8 settembre (una data fatidica per l’Italia) 2015, nel caso Taricco, affermava testualmente nel dispositivo che “una normativa nazionale in materia di prescrizione del reato come quella stabilita dal combinati disposto dell’articolo 160, ultimo comma, del codice penale, come modificato dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, e dell’articolo 161 di tale codice, normativa che prevedeva, all’epoca dei fatti di cui al procedimento principale, che l’atto interruttivo verificatosi nell’ambito di procedimenti penali riguardanti frodi gravi in materia di imposta sul valore aggiunto comportasse il prolungamento del termine di prescrizione di solo un quarto della sua durata iniziale, è idonea a pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dall’art. 325, paragrafi 1 e 2, TFUE nell’ipotesi in cui detta normativa nazionale impedisca di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gl’interessi finanziari dell’Unione Europea (…) Il giudice nazionale è tenuto a dare piena efficacia all’art. 325, paragrafi 1 e 2, TFUE disapplicando, all’occorrenza, le disposizioni nazionali che abbiano per effetto di impedire allo Stato membro interessato di rispettare gli obblighi impostigli dall’art. 325, paragrafi 1 e 2, TFUE”.
Ce n’era a sufficienza per porre mano ad una riforma che perlomeno scongiurasse il rischio che fossero i giudici a dover decidere, caso per caso, se la brevità della prescrizione comportasse violazione della normativa comunitaria, ed in ipotesi a disapplicarla. Si giunge così (altrimenti non ci si sarebbe mai giunti) alla cosiddetta “riforma Orlando” (legge n. 103 del 2017), che avvia un solo parziale miglioramento della situazione. Oltre ad aver moltiplicato, rispetto alla Cirielli, le ipotesi di reato per le quali i termini ordinari di prescrizione sono raddoppiati (cosa che accentua la disarmonia del sistema), la riforma lascia inalterato l’art. 161 secondo comma (il vero nodo del problema), che fa scattare inesorabilmente la prescrizione se i termini ordinari, a seguito della loro ripetuta interruzione con atti del procedimento, sono comunque oltrepassati di solo un quarto (senza neppure tornare alla pur blanda disciplina voluta da Rocco, con l’aumento fino alla metà) e, cosa ancor più grave, neppure ritocca la Cirielli nella parte in cui fa dipendere la prescrizione dalle qualità soggettive del reo, creando un doppio regime di prescrizione a danno dei recidivi aggravati. L’unico miglioramento sostanziale del problema deriva (a parte l’attenzione posta ai reati su minori, facendo decorrere la prescrizione dalla maggiore età della vittima) dall’aver previsto la sospensione della prescrizione dopo la sentenza di primo e di secondo grado, ma per un massimo di un anno e mezzo in ciascuno dei due casi. La norma individua la radice del problema (le impugnazioni), ma lo risolve in modo poco soddisfacente, perché assegna a ciascun grado di giudizio successivo al primo una durata che non è realistico attendersi, per i motivi che presto si diranno.
Infine, la legge n. 3 del 2019, fortemente voluta dall’attuale Guardasigilli e dal suo Movimento, e fatta ingoiare anche al recalcitrante alleato di governo dell’epoca (che ne ottenne come contropartita il rinvio al 1° gennaio 2020 dell’entrata in vigore, in attesa della mitica “riforma della giustizia”), pur non scardinando del tutto l’impianto normativo della prescrizione come sedimentato dalle normative Rocco-Cirielli-Orlando (resta ancora in vigore l’art. 161 nel testo previgente) ne disinnesca tuttavia la garanzia d’impunità in esso contenuta, adottando il modello svizzero della sospensione (anche se il codice penale svizzero parla, più correttamente, di “estinzione” della prescrizione) dalla sentenza di primo grado fino alla sentenza definitiva. In pratica, la prescrizione spiega i suoi effetti soltanto fino alla sentenza di primo grado.
Il pregio della soluzione adottata consiste nell’implicito riconoscimento che è l’uso strumentale e dilatorio delle impugnazioni la vera causa (e, al tempo stesso, in un circolo vizioso, a sua volta l’effetto) del numero abnorme di prescrizioni che si verifica, e dell’effetto impunità che ne deriva. In un recente intervento (su “Il Fatto Quotidiano” del 5 dicembre scorso), il Procuratore Generale di Palermo, Roberto Scarpinato. osserva che, limitandosi ad interrompere il decorso della prescrizione solo dopo la sentenza di primo grado, restano fuori dal raggio di azione della riforma la maggior parte delle prescrizioni, che, nella misura del 65% dei casi, si verifica nelle fasi precedenti (durante le indagini, o durante il primo grado). L’osservazione è senz’altro giusta, come è giusta la conseguente richiesta di un impegno volto a ridurre il numero di tutte le prescrizioni. Vi è tuttavia da aggiungere che le prescrizioni che vengono dichiarate dal GIP con decreto di archiviazione su richiesta del P.M., spesso, hanno ad oggetto non tanto reati che si prescrivono nel corso del procedimento, quanto reati che vengono denunciati a prescrizione già avvenuta (ad esempio, nel caso degli abusi edilizi, non di rado capita che i Comuni, per mero scrupolo, cioè per assolvere all’obbligo di denuncia, segnalino all’Autorità Giudiziaria fatti assai risalenti, ed ampiamente prescritti, di cui vengono a conoscenza per motivi fortuiti, o a seguito di una domanda di sanatoria), il che è tutto sommato fisiologico. Ma non solo. Le prescrizioni che si verificano nella fase delle impugnazioni, infatti, conseguono molto spesso (e diversamente da quanto avviene in genere nel corso del primo grado, benché i comportamenti ostruzionistici siano possibili anche in questa fase) ad un abuso del diritto, cioè ad un ricorso strumentale all’impugnazione solo per far scattare la prescrizione stessa. Il che ha, come effetto conseguente, l’intasamento dei ruoli delle Corti di appello, con ulteriori negative ricadute sui tempi di definizione.
Va infatti precisato (e con questo è facile rispondere anche alle critiche di chi paventa un “processo infinito” a seguito della riforma) che, anche se l’ordinamento prevede tre gradi di giudizio, non è obbligatorio percorrerli tutti per giungere ad una sentenza definitiva. La Costituzione (art. 27) afferma che “l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”, non “fino alla sentenza di cassazione”, come spesso si sente dire superficialmente dai mezzi d’informazione. Definitiva può essere anche una sentenza di primo grado, se non viene tempestivamente impugnata. La regola della “doppia conforme” (quella secondo cui ogni sentenza, per diventare definitiva, andava riveduta da un secondo organo giudiziario che l’approvasse a sua volta) valeva solo nell’ordinamento canonico, e oggi neanche più in quello, avendola Papa Francesco provvidenzialmente abolita. In appello non ci si va automaticamente, ma solo se qualcuno (l’imputato o il P.M.) lo richiede; e lo stesso vale per il ricorso per cassazione. L’allungamento del processo richiede quindi la volontà dell’interessato. Contro le sentenze civili dei tribunali, nel 2017, è stato proposto appello nel 24,8 % dei casi in materia ordinaria, e nel 21,1% in quella di lavoro e previdenza. Nel penale, le sentenze dei tribunali ordinari sommano, nel 2017 (al netto di quelle di appello sulle sentenze dei Giudici di Pace, di quelle di patteggiamento, che non sono appellabili, e di quelle di prescrizione, contro le quali è assai raro che venga proposto appello) a circa 345.000, mentre gli appelli contro tali tipologie di sentenze proposte alle Corti d’Appello sommano a 117.000, circa il 33% del totale; ma il dato statistico non tiene conto del fatto che molte sentenze di primo grado sono di assoluzione; se si dovesse individuare il tasso di impugnazione delle sole sentenze di condanna, la percentuale salirebbe fortemente. Ma vi è di più: su un totale di circa 398.000 sentenze dei tribunali ordinari (al netto di quelle pronunciate in grado di appello, sulle sentenze dei GdP), solo 27.436 sono di prescrizione, cui ne vanno aggiunte 10.000 pronunciate dai GUP, in totale 37.436, pari al 9,4%. Una percentuale, pertanto, elevata, ma ancora tollerabile. Sempre nel 2017, invece, su 109.403 sentenze pronunciate dalle Corti di appello, ben 28.185 sono di prescrizione, oltre il 25% del totale! E’ qui, nell’appello, il vero collo di bottiglia del sistema, un sacrosanto strumento di garanzia che il meccanismo di prescrizione ha trasformato in una fabbrica d’impunità (e, quindi, d’iniquità).
Il problema deriva, in gran parte, dall’insufficienza del personale di magistratura, o quantomeno da una sua distribuzione sul territorio non proporzionata al carico di lavoro. Nel 2017, per esempio, si sono conclusi per prescrizione il 35,9% dei processi definiti dalla Corte d’Appello di Roma (4.226 su 11.754), ed il 32% dei processi definiti dalla Corte di Napoli (4.020 su 12.549), mentre davanti alla Corte d’Appello di Milano la percentuale è solo del 9,9 (809 processi su 8.160); mentre la Corte d’Appello di Trento raggiunge il record del minimo delle prescrizioni (solo 7 su 562 processi definiti, ossia l’1,2%). Ma non che a Trento o a Milano lavorino di più che a Roma o a Napoli, anzi. Il problema è che i magistrati della Corte d’appello di Milano (tra presidente, presidenti di sezione e consiglieri, esclusi quelli addetti alla sezione lavoro) sono in organico 115, e sempre nel 2017 a quella corte sono stati proposti 7.683 appelli penali, ossia 66,8 per magistrato (in pratica la cifra andrebbe raddoppiata, perché una buona metà dei magistrati sono addetti al civile, ma dai dati ufficiali non è possibile precisarlo; comunque il discorso andrebbe fatto anche per le altre corti, quindi non incide sui confronti), mentre a Roma sono stati oltre il doppio (130,91, dividendo i 17.542 appelli per i 134 magistrati) e a Napoli anche di più (131,63, dividendo i 16.323 appelli per i 124 magistrati). A Trento, maglia rosa d’Italia, i magistrati sono 14 oltre a 7 della sezione distaccata di Bolzano, in totale 21, che hanno ricevuto complessivamente 636 appelli, pari a 30,25 a testa. Facile far bella figura con quel carico di lavoro. Il problema della lentezza dei processi, perciò, non si risolve prospettando la mitica “riforma della giustizia” che è solo uno slogan vuoto, e tantomeno assoggettando i magistrati al controllo della politica (che ha anzi troppo spesso interesse a che i reati si prescrivano…), o introducendo un’organizzazione più “manageriale”, sul modello aziendalistico neoliberista, ma adeguando le forze disponibili ai carichi di lavoro. Anche perché le statistiche sulle prescrizioni dichiarate non dicono tutto. A Roma, per esempio, a fronte (sempre nel 2017) di 17.542 appelli pervenuti nell’anno, e di 11.754 definiti, ne restavano pendenti a fine anno (ossia da trattare) 56.301; a Napoli, a fronte di 16.323 iscritti e 12.549 definiti, ne restavano pendenti 47.745 (a Milano solo 8.460, a Trento 652). Quanti dei processi esistenti in questi “giacimenti” semi-occulti sono già prescritti? E’ una cifra del tutto ignota, perché la politica dei dirigenti nel fissare i ruoli potrebbe oscillare tra il far emergere le magagne per ripulire gli armadi e ripartire da zero, e il tenere la spazzatura sotto il tappeto (finché un processo prescritto non viene portato in udienza, sarà difficile sapere che è prescritto).
Le statistiche, infine, mostrano anche il circolo virtuoso che la riforma della prescrizione potrebbe produrre, tramite un maggior ricorso ai riti alternativi, così alleggerendo anche gli uffici di primo grado e diminuendo le prescrizioni anche lì, e che non è solo una congettura o un auspicio: se si osservano i dati delle tipologie di definizione negli uffici GIP-GUP aggregati per distretto, si vede come le maggiori prescrizioni in appello si accompagnino a una scarsa propensione ai riti alternativi in primo grado, e viceversa. Nei tribunali del distretto di Roma, ad esempio, ancora nel 2017, gli uffici GIP-GUP hanno definito con sentenze a seguito di rito alternativo 2.930 processi a fonte di 9.727 rinvii a giudizio (grosso modo un terzo), in quelli del distretto di Napoli le sentenze di rito alternativo sono state 3.148 a fronte di 8.726 rinvii a giudizio (poco più di un terzo). Nel distretto di Milano, invece, le sentenze del primo tipo sono state 5.679 a fronte di 6.437 rinvii a giudizio: siamo quasi al pareggio. E a Trento? Qui le sentenze di rito alternativo sono 950, ossia superano i rinvii a giudizio, che sono solo 678. Evidentemente l’aspettativa dell’impunità grazie alla “prescrizione garantita” produce i suoi effetti anche sulle scelte processuali delle difese.
*L’autore è socio del Circolo LeG di Firenze, ex magistrato, ex funzionario parlamentare.